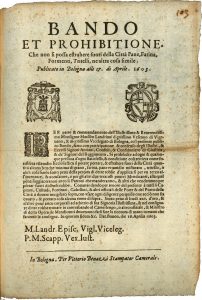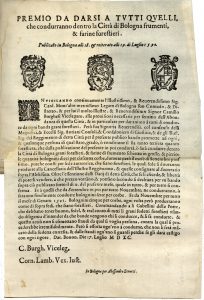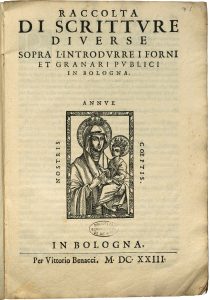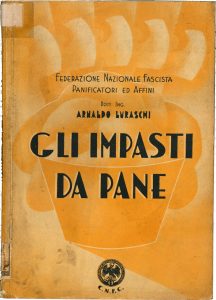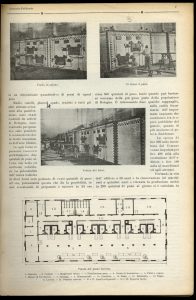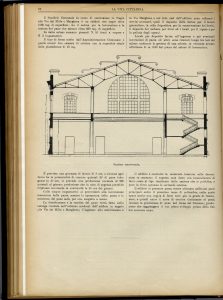Il garzone del fornaio, anche d’inverno indossava maglietta e pantaloni corti, arrivava col triciclo carico di cestoni colmi di pane: profumo caldo, biscottato, dolce che trasuda dalle bianche coperte e si spande alle prime luci.
Da queste parti il pane è gran cosa, sacra; quasi tutto, se non fosse per il ghiotto companatico che seguirà, Al pan sótt fà i bî pótt (“il pane asciutto fa i bambini belli”).
Pochi ingredienti: farina, acqua, sale, lievito, in certi casi l’aggiunta di strutto (per nulla originali) trasformati con abilità paziente, ritmata e forsennata nella notte per accontentare l’occhio della massaia. I vecchi rammentano il filone (filån, filunzén), la pagnotta, il barilino (barilén), la croce (cruṡatta), la treccia (trazza), il panetto (panàtt); chi desiderava la crosta ben cotta, chi preferiva la muläṅna (“mollica”) soffice e spugnosa.
Nel cassone del panificio s’affacciavano i figli dei meno abbienti, ad occhi bassi, vergognosi, allungando le mani per recuperare in fondo grustén (“crostini”), grugnù (“comini”): perfino äl brîṡel (“le briciole”).
Che importa se la bianca pasta non è argilla e neppure scagliola; il senso artistico e il gusto del bello spronavano le risorse fantasiose dei panettieri, che alle forme già citate, aggiunsero il nastro (nâster), la esse, la foglia (fójja), la rosetta (ruṡatta), la banana, il carciofo (scarciòfel), la lumaca (lumèga), il ragno (râgn), la spoletta (spulatta), e altre ancora, immaginiamo, ne affiancheranno un giorno, sempre che il progresso non riduca anche quest’arte fornaria vittima del cellophan e della plastica con l’obbligatorietà, mi si dice, dell’uso di prodotti conservanti.
La mattina, prima d’andare a scuola, si passava in bottega: chi preferiva la merenda dolce poteva scegliere fra una fetta di pénza (“pinza”, impasto arricchito di mostarda, marmellata o uva appassita) o di brazadèla (“ciambella”). Io, invece, e non ero il solo, acquistavo cinquanta lire di carsänt al fåuren (“crescente al forno”) farcita con i ritagli del prosciutto, ciclétt.
Il testo è tratto da: Alessandro Molinari Pradelli, Osterie e locande di Bologna. La grassa e la dotta in gloria della tavola: folclore, arte, musica e poesia nelle tradizioni contadine e gastronomiche della città felsinea, Roma, Newton Compton, 1980
Collocazione: 17. T. V. 75